Focus
L’esame di dottorato: racconto semitragico di una giornata di ordinaria università
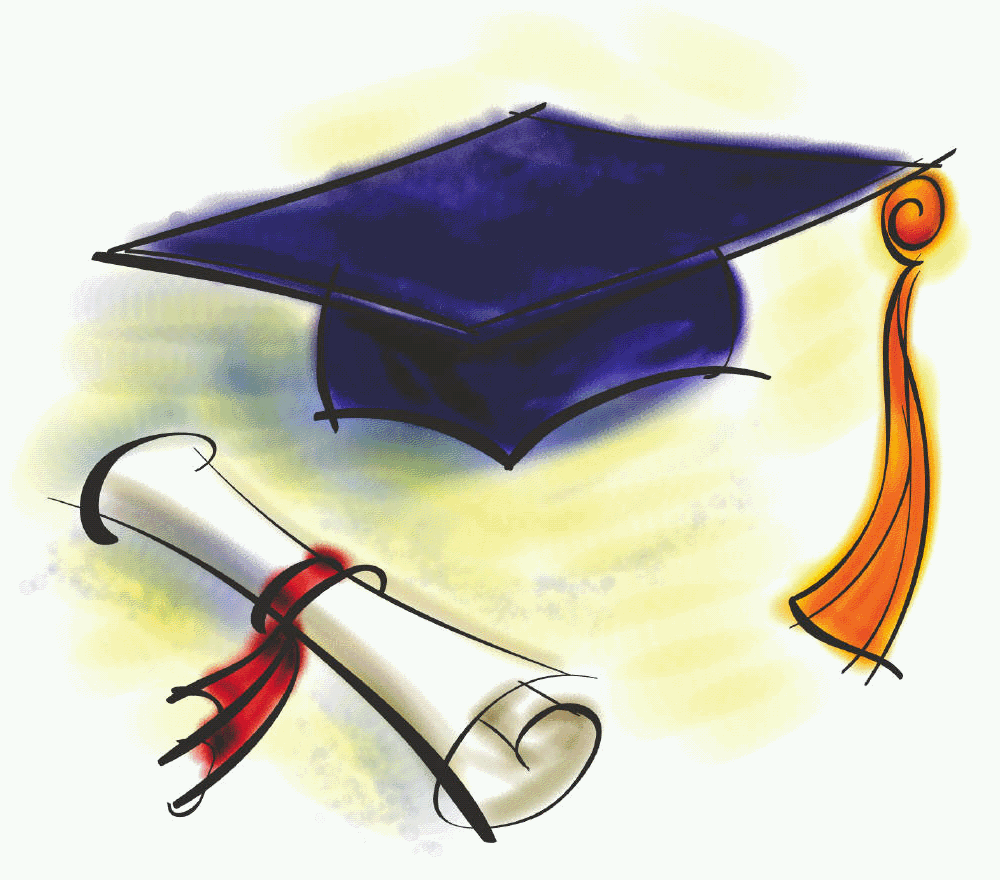
Torna Sandro Gianni per l’ottava puntata di ST.O.P.
Dopo il colloquio con Ryanair, il racconto di un esame di dottorato. Un duello d’altri tempi, tra baroni e cavalieri ma senza cavalli bianchi. Una romantica sfida e come sfondo una Palermo accogliente e popolare…chi sarà il vincitore?
:: Tanti di quelli che hanno attraversato l’università sottopelle nascondono una cisti. Un coagulo di tempo ed energie, spesso di rimorsi e delusioni. C’è chi un dottorato non l’ha mai vinto, ma avrebbe voluto vedere, almeno per una volta, com’è fatto un contratto di tre anni. C’è chi l’ha ottenuto, ma si è accorto solo alla fine di avere in mano una conclusione più che un nuovo inizio. C’è anche chi ha lavorato per trentasei mesi senza vedere un euro, né, dopo, uno straccio di prospettiva.
Io ho provato cinque dottorati, di cinque discipline, in cinque città. Uno l’ho preso, ma «senza borsa». Ho rifiutato. Nella maggior parte dei concorsi non meritavo niente, avevo studiato male o scritto in fretta, ero arrivato svogliato o disilluso. Ma c’è sempre una volta che fa male. La prima. È come un rimosso, non ci pensi più e poi… poi fai un colloquio a Ryanair in giacca e cravatta e puff: ti ritrovi seduto davanti alla commissione.
Palermo. Ottobre 2011. Il sole spacca l’asfalto dei quartieri popolari del centro. Le scritte intorno alla zona universitaria sono cicatrici di un’onda infranta da non molto. La fuliggine ricopre la pelle dei Quattro Canti, allo snodo tra Ballarò e la Vuccirìa. Dalla stanza che ho preso in affitto alla facoltà di giurisprudenza non corre alcuna ipotenusa: bisogna percorrere i cateti che disegnano un angolo a novanta. Intorno a uno spigolo di piazza Vigliena.
Jeans, camicia, giacca e cravatta. Ho imparato a fare il nodo durante l’estate, indossandola durante i matrimoni. Per servire il cibo non infastidiva. Per andare all’università sì. È giorno, fa caldo, stringe il collo. Per strada, gli altri sono vestiti come si deve: comodi. Ma questa facoltà è diversa da quella in cui ho studiato. Mi hanno detto che si usa così.
Tempo massimo tre ore. Argomento a sorpresa. Fogli e penna. Cellulari e zaini all’ingresso. Solo per l’occasione, un orologio da polso steso sul tavolo. È lo scritto. Sulla ruota di Palermo viene estratto un tema che riguarda la protezione di foreste, parchi marini e specie faunistiche da un profilo costituzionale. Rimango perplesso. Ma inizio a scrivere. Tic tac, tic tac. La lancetta sembra muoversi più veloce del solito. Tic tac, ti tac. Sudo, provo ad allargarmi il nodo della cravatta, ma quello si strozza. Tic tac, tic tac. Mi tolgo la giacca. Le scarpe devo tenerle. Tic tac, tic tac. Inchiostro, inchiostro, inchiostro. Tic tac, tic tac. Sguardi furtivi attraversano la stanza. Sudore. Agitazione. Tic tac, tic tac. I crampi. Le dita della mano destra continuano a contrarsi. Le tiro una a una con la sinistra. Si stirano. Riprendo la penna. Si accartocciano di nuovo. Tic tac, tic tac. Non sono più abituato a scrivere senza una tastiera. Tic tac, tic tac. Continuo a vomitare parole sul foglio. Articoli di leggi che mai avrei pensato di sapere. Tic tac, tic tac. Riguardo la forma delle parole, delle lettere. Persino a me pare incomprensibile. Altre gocce di sudore. Non sono bastati i richiami alla lavagna, la gogna pubblica alle elementari e alle medie, l’esibizione dei miei compiti in classe quasi fossimo al circo. La grafia non si è mai uniformata a nessuno degli unicode tra cui potevo scegliere. Tic tac, tic tac. Forse devo tradurlo in stampatello. Altrimenti non capiranno niente. Tic tac, tic tac. I crampi. La grafia. Che numero era quell’articolo? Rileggere. Correggere. Riscrivere. Tic tac, tic tac. Driiiin. Tempo scaduto.
Consegnare.
Pausa. Bar: aria condizionata, panino con le melanzane fritte, caffè. Comunque vada, bella la vita! Fuori il sole insegue le rotondità barocche di terrazze e portoni. Le voci del mercato si mischiano al rumore del traffico. L’odore di pesce a quello di smog. Palermo del sud, Palermo metropoli. Tre anni in riva a questo mare amico, in braccio a un centro città che turismo e decoro non hanno ancora potuto imbalsamare. Sarebbe bello, ma già so: i dottorati non si vincono studiando. Me l’hanno ripetuto gli amici più grandi ed esperti: devi conoscere qualcuno in commissione, devi conoscere dei professori potenti, devi conoscere gli sfidanti e le loro relazioni. Eppure, sotto sotto, non riesco a convincermi che sia del tutto impossibile. Confido nell’imprevisto, nell’eccezione. In un interstizio nascosto ma presente. Dentro cui tuffarmi di testa.
La pausa sta per finire. I risultati si avvicinano. Scritto e titoli insieme. Più tardi l’orale, la terza parte del voto. Il bar con l’aria condizionata dista solo pochi minuti dall’atrio fresco della facoltà. Per strada gocciolo tensione. Dentro l’università evapora nervosismo. Gli altri candidati ronzano intorno. Mi unisco a quello sciame che passeggia su e giù per non pensare. Ascolto i discorsi. Qualcuno si lamenta perché ancora non si sanno i criteri con cui verranno valutati i titoli. Circola la voce che daranno più punti per i master che per il voto di laurea. Una ragazza mi dice: «Ti sembra giusto che un master a pagamento che dura sei mesi valga più del massimo dei voti dopo cinque anni di giurisprudenza?». «Non lo so, ho fatto lettere», scherzo io. «Secondo me vogliono far passare quella: si è laureata con 76», mi dice indicando un’altra sfidante. Non bado troppo ai pettegolezzi.
Arriva il foglio. Viene appeso. Ci ammassiamo là davanti. Le tempie pulsano. Il dito trema. Lo faccio scorrere sulla classifica alla ricerca del mio nome. Dal basso verso l’alto. Ci sono due colonne. Comincio da quella a destra. Arrivo in cima senza trovarmi. Sento battere il cuore nelle mani e nei piedi. Seconda colonna: eccomi intorno alla metà. Leggo le lettere del mio cognome da sinistra verso destra: giusta, giusta, giusta, giusta…. diversa. Avranno sbagliato. E invece no, ho sbagliato io. C’è uno che ha quattro quinti di cognome uguale al mio. Ma il suo è al singolare, finisce in o. In una frazione di secondo capisco che o sono molto in alto, o sono fuori. Ci sono sei posti. Tre con borsa, tre senza. Delle decine di candidati iniziali, solo quarantacinque hanno superato lo scritto. Ventitré sono nella colonna destra. Ventidue in quella sinistra. Sono a metà: ci sono 11 posizioni possibili. Oppure l’esclusione. Ma non ci credo che mi hanno bocciato: quello che ho scritto me lo ricordo e sono sicuro di aver superato la prova. Resta l’incognita della grafia. Lentamente scorro verso l’alto. Ogni cognome diverso dal mio è un sussulto, un battito. Il dito entra nei primi sei posti. Forse sono nei play-off. Sesto: no. Quinto: no. Quarto: no. Forse sono sul podio. Bronzo: no. Argento: sì. Sono secondo!
Rido. Il secondo impulso è chiamare qualcuno, per dire che potrei farcela. Che forse i dottorati si prendono senza raccomandazioni e al primo colpo. Che è possibile. Invece spengo il telefono e inizio a ripassare il mio progetto di ricerca. Ci ho lavorato quasi tre mesi. La tesi si può riassumere con un’equazione.
stato d’eccezione : sovranità = stato d’emergenza : governance
Devo solo presentarlo, penso. A parlare me la cavo, mi dico. L’orale è sempre stata la mia parte preferita, ricordo.
Andiamo in aula. Iniziano a chiamare. Ci sono interrogazioni e interrogatori. Ci sono movimenti che con gli occhi non vedo. Scambi di parole che non posso ascoltare. I primi che vengono interrogati sono posizionati abbastanza in fondo. Hanno poche speranze. Quando convocano il terzo in classifica, la cosa inizia a diventare interessante. «Il suo progetto di ricerca è simile al tema che è uscito allo scritto», mi sussurra da dietro un altro concorrente. In diversi hanno già scommesso su di lui: la corsa è truccata; è il cavallo vincente. Ma in pochi minuti le sue quotazioni crollano. Mentre presenta con disinvoltura il progetto, viene interrotto dal Presidente della Commissione, che gli chiede: «Secondo lei è possibile parlare di diritti delle generazioni future senza una prospettiva anti-abortista?». Esplode il silenzio. L’interrogato sbianca. Non riesce a balbettare. Non si aspettava il colpo a bruciapelo, ma evidentemente sa chi ha di fronte e cerca le parole per diluire quello che ha scritto nel progetto. Il professore rimane impassibile, di viola ha solo il cognome. Gli altri sono in ascolto, si agitano, si muovono. Lo scricchiolio delle sedie punteggia la distesa di silenzio. Sono sicuro che qualcuno stia sghignazzando di nascosto, anche se non posso vederlo.
Da parte mia, sento il nodo della cravatta che mi prende il collo, come Homer fa con Bart. La mente insegue i personaggi con cui ho popolato la bibliografia e non riesco a deglutire. Penso a quel Carlo che paragonava la fede a un oppiaceo e con i cui libri sono state accese chiese e preti. A quel Michele che amava gli uomini e usava la religione per descrivere il potere. O a quell’Antonio che in Italia è considerato un maestro cattivo. Si mette male.
Tocca a me. Ho fatto un respiro profondo prima di entrare in aula e sedermi di fronte alla commissione. Come spesso mi accade in queste occasioni, l’adrenalina ha invaso le sinapsi: al posto della tensione è subentrata un’elettrica eccitazione. Non sudo. Ho il battito regolare. Sorrido a destra e a sinistra con fare disinvolto, per mostrare a chi mi esamina di non avere timore. Il Commissario Capo esordisce con queste parole: «La sua bibliografia è troppo scarsa». Secco. Vuole mandarmi in palla. Io sorrido di nuovo e con calma rispondo. «Alla luce dello spazio ristretto che avevamo a disposizione e della complessità del progetto, ho incluso solo una piccola parte degli autori studiati». Per questo la bibliografia che compare è solo di due pagine (su sei). Parlando, lo invito a dare un’occhiata all’elenco integrale di nomi e opere. Una decina di pagine fascicolate che allungo verso di lui. Istintivamente dovrebbe aprire le dita della mano e poi chiudere pollice e indice per afferrare il foglio. Magari buttando velocemente un occhio sui nomi incolonnati accanto alle opere. Oppure, potrebbe dirmi che questa procedura è irregolare. Invece il Grande Prof, noto esponente di quel residuo di classe nobiliare che ha squarciato la fine del feudalesimo incrostandosi nei corridoi universitari, resta impassibile. Mi guarda fisso negli occhi senza accennare alcun movimento, di mani o di bocca. Non fa cenno a quel foglio.
Capisco. Visto che non ho niente da perdere, posso combattere senza paura. L’interrogatorio diventa una sfida furiosa tra il barone a cavallo e il fante. Dal basso, rispondo colpo su colpo agli attacchi. Invece della spada utilizzo Schmitt e Foucault, i dibattiti in seno all’assemblea costituente tra il ’46 e il ’48, i capoversi degli articoli della carta costituzionale e dei regolamenti comunali. Quello dall’alto continua a scagliarmi fendenti, ma il mio scudo regge. Nel combattimento si inseriscono le due professoresse che compongono la commissione. Mi aspetto nuovi colpi ai lati e invece mi offrono protezione. Mi lanciano un elmetto che raccolgo. Intorno, la polvere si è alzata ovunque. O almeno, così pare a me che combatto a piedi. Forse dall’alto dell’equino la prospettiva è diversa e quella nuvola neanche si vede. Dopo quasi un’ora, il duello viene interrotto. Durante i pochi passi che mi trasportano fuori dall’aula, l’adrenalina evapora, l’arena scompare, rivedo i banchi, il corridoio, l’icona che indica il bagno. Incrocio gli sguardi degli altri. Alcuni mostrano stima, altri sdegno. Chissà perché.
Il coordinatore del dottorato, invece, non riesco a guardarlo negli occhi. Mi avvicino. Provo a dirgli qualcosa. Quello abbassa o alza le pupille. Chissà perché. Era stato così gentile a fornirmi le informazioni più importanti sull’esame, a dirmi in confidenza che è possibile prendere il dottorato senza raccomandazioni. A differenza della maggior parte degli altri concorsi. Adesso, però, è sfuggente. E infatti si gira e imbocca le scale, salutando con la mano quando è già lontano.
La lancetta dei minuti gira in tondo almeno quaranta volte prima che le porte si riaprano. Stavano discutendo il mio voto. Solo quando rientro e mi metto a sedere, tra il pubblico stavolta, mi rendo conto che quelli prima di me erano stati votati molto più in fretta. Cinque, massimo dieci minuti. Chissà perché.
Intanto chiamano il candidato successivo. Procedono in ordine alfabetico. Di conseguenza, tocca al ragazzo che ha il cognome uguale al mio, ma al singolare. Si siede. Non è tanto quel «Ci parli del suo progetto» con cui esordisce il Grande Capo a stupirmi, quanto il sorriso scintillante che ne decora la bocca mentre pronuncia quelle parole. Stavolta è sceso da cavallo e con fare cortese porge all’ospite la mano coperta da un guanto di velluto. Lo invita a entrare nel castello. La chiacchiera dura una ventina di minuti. Poche domande, nessuna obiezione. Neanche di coscienza. Si chiudono le porte e poi si riaprono. Quasi subito. Evidentemente dopo poche parole. Intanto l’ospite è uscito dall’aula senza guardare nessuno, tranne la fidanzata che lo apettava sorridente. Dopo un bacio veloce, si dileguano per le scale e se ne vanno.
Me ne vado pure io. Passo da casa. Mi tolgo il vestito, le scarpe eleganti e soprattutto quella insopportabile cravatta. Mi metto comodo. Vado a bere in mezzo alla gente che urla, seduto sulle cassette del mercato. A Ballarò mi sento di nuovo a mio agio. Mangio nella trattoria più rustica che trovo. Non basta così poco a togliermi l’appetito.
Quando è sceso il fresco e l’asfalto ha smesso di bruciare, espongono i risultati da una porta di servizio della facoltà. Che scena strana. Stiamo là dietro come fossimo ladri, ad aspettare un foglio che segnerà il destino di alcuni di noi. Un uomo lo appiccica da dietro il vetro di una porta chiusa a chiave. Subito dopo si allontana in fretta. Inghiottito dal buio del corridoio della facoltà. Lo vedo solo da lontano. Di spalle, mi sembra il coordinatore.
Ovviamente non vinco il dottorato con borsa. E nemmeno senza. Arrivo settimo. I posti sono sei. Pazienza. È fuori anche il ragazzo che non aveva adottato la prospettiva anti-abortista. Bocciati politici, mi dico con orgoglio. Poi, però, mi accorgo che la ragazza campione d’inverno dopo la prima prova non solo era fuori dai play-off, ma era stata proprio eliminata. Davvero lei che aveva superato tutti con i titoli guadagnati nel tempo e su un tema estratto a caso tra i milioni possibili è cascata proprio sul suo progetto? Ho perso la sua discussione, ma non ci credo. Comunque, sul podio ci sono sia quello col cognome uguale al mio ma al singolare, che quell’altra che si era laureata con 76 ma aveva pagato il master.
Il giorno dopo ritorno in facoltà. Vorrei fare qualche domanda al coordinatore: quando ci metti tempo, energie e soldi… tentare nuoce. Eccome. Non lo trovo. Non risponde neanche al telefono. Nei corridoi incrocio il mio quasi-omonimo. Indossa ancora giacca e cravatta. Si muove comodo tra le aule dei ricevimenti.
Oggi, quasi sei anni dopo, il dottorato ancora non ce l’ho. E forse non ce l’avrò mai. I tentativi successivi li ho fatti senza entusiasmo e senza studiare. Se solo uno su mille ce la fa, il gioco non vale la candela. Soprattutto, però, dopo sei anni ho visto dottorarsi dozzine di amici e conoscenti. Con o senza borsa. Tanti di loro senza conoscenze, né raccomandazioni. Finiti i tre anni, quasi tutti si sono ritrovati al termine di una strada senza uscita. La questione, dunque, non è né di merito individuale, né di corruzione. L’esito personale di quel concorso del 2011 non conta niente. Anzi, forse è stato meglio così. La sconfitta vera è un’altra: è quella subita in massa l’anno prima, nelle strade. Quando è finita quell’Onda che prima di infrangersi aveva provato a disegnare un futuro diverso per un’università che, ormai, sembra capace solo di declinare al passato persino il suo presente.
Se volete inviare la vostra storia di un colloquio o di un’esperienza lavorativa scrivete a info@clap-info.net